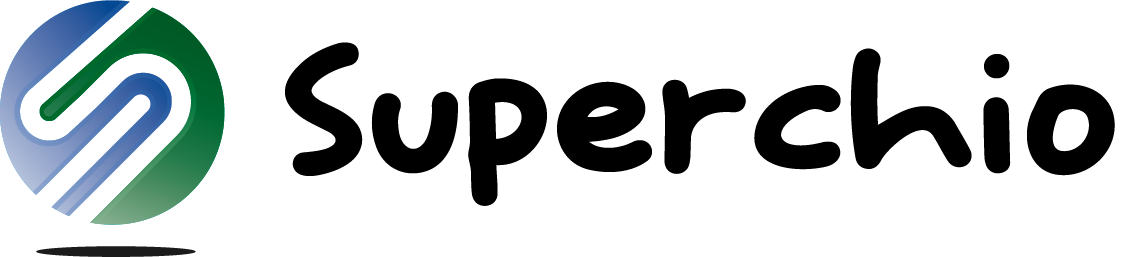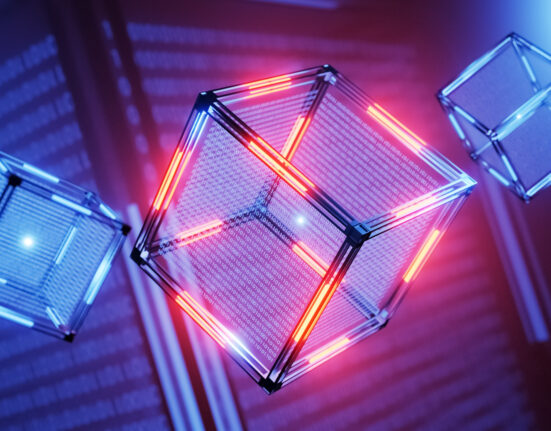Sottoscritta il 25 settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri delle Nazioni Unite, e approvata dall’Assemblea Generale dell’ONU, l’Agenda 2030 è un progetto costituito da 17 Macro Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile, identificati all’interno di un più ampio programma d’azione redatto in 169 punti da raggiungere entro il 2030, riguardanti criteri ambientali, sociali ed economici.

Questo programma non è mirato a risolvere tutti i problemi che interessano il nostro pianeta, ma rappresenta una base di partenza per costruire un mondo migliore. Una “good practice” globale per l’impegno nazionale ed internazionale teso a trovare soluzioni comuni alle grandi sfide del pianeta, quali il cambiamento climatico, l’estrema povertà, la lotta contro l‘ineguaglianza, il rispetto dei diritti umani o il degrado dell’ambiente.
Chi sono gli attori coinvolti in questo programma? L’industria della moda fa parte di questi?
La realizzazione dei target imposti dell’Agenda 2030 richiede un forte coinvolgimento di tutte le componenti della società, dal settore pubblico alle aziende private, dalla collettività civile ai divulgatori di informazione e cultura. Anche per l’industria della moda, sulla base degli impatti ambientali ed etici verificati negli ultimi decenni, si è concretizzata la necessità di cambiamenti fondamentali nel modello di business. Tra queste spiccano una decelerazione della produzione e l’introduzione di pratiche sostenibili a lungo termine su tutta la filiera, nonché un cambiamento nelle politiche sociali per garantire condizioni di lavoro adeguate ed evitare lo sfruttamento dei lavoratori.
Per anni il mondo del fashion è sembrato distante dall’idea di sostenibilità e da concetti come digitalizzazione e tracciabilità. La responsabilità sociale dei brand era un aspetto secondario: l’attenzione era focalizzata sul design o l’estetica del prodotto. Nel 2020, la pandemia ha stravolto l’ordine tradizionale di queste dinamiche, evidenziando l’importanza della sostenibilità e accentuando la necessità di un sostanziale impegno, iniziato già da qualche anno da parte di alcune aziende di moda, verso il rispetto e la salvaguardia del nostro pianeta.
L’industria del fashion è chiamata quindi a rispondere all’incombente esigenza di azioni correttive efficaci per diminuire l’inquinamento, nonché alle richieste del mercato. Questo implica produzioni sempre più attente in termini di impatto ambientale e responsabilità sociale, con l’obiettivo di creare un sistema basato su un’economia circolare e non più lineare “take-make-dispose”.
E noi consumatori siamo coinvolti? Anche noi possiamo contribuire a questo cambiamento?
Certo! Anzi, dobbiamo! È importante capire, che le azioni appena citate non riguardano solo le grandi industrie. Queste hanno sicuramente un ruolo in prima linea nel mettere in atto strategie per abbattere le emissioni e rendere sempre più sostenibili le rispettive attività; ma spesso ci si dimentica come il vero cambiamento possa arrivare “dal basso”, mettendo in pratica semplici ma preziose azioni che possono, nel tempo, salvaguardare l’ambiente e il pianeta che ci ospita.
Il modo in cui realizziamo, utilizziamo e ci liberiamo dei nostri abiti è diventato oramai insostenibile! In questo momento storico è fondamentale un cambiamento nel comportamento di noi consumatori, a partire proprio da quelle pratiche quotidiane che facciamo ormai in modo così automatico da sembrare banali. Ad esempio evitando di gettare abiti che possono essere riutilizzati o riparando, laddove possibile, un capo danneggiato, aumentando così la durata degli indumenti e diminuendo gli acquisti di abbigliamento non necessari.
Ma come impatta l’industria del fashion sullo sviluppo sostenibile? Facciamo degli esempi concreti facendo riferimento ai punti dell’agenda.
A pochi mesi dall’inizio del 2023, il settore moda registra un valore globale prossimo ai 3 mila miliardi di dollari, impiega oltre 50 milioni di persone, e rappresenta la seconda industria più inquinante al mondo. Bisogna quindi considerare la moda come una questione sociale, dato che i dati relativi all’impatto ambientale ed umano di questa industria sono più che idonei a qualificarla come tale.
Agenda 2030: 17 obiettivi per lo sviluppo sostenibile

Punto 1
“Sconfiggere la povertà”. È ormai cosa nota che l’industria tessile, soprattutto quella del fast fashion, tende a retribuire i lavoratori con un salario inferiore al minimo consentito, senza dare possibilità ai dipendenti di contrattare sullo stipendio, e costringendoli a condizioni di lavoro disagiate e spesso disumane.
Per riportare alcuni dati concreti, nel 2020 La Clean Clothes Campaign lancia il report “Fuori dall’ombra: riflettori puntati sullo sfruttamento nell’industria della moda”. La ricerca viene condotta attraverso questionari inviati a 108 marchi e rivenditori di 14 Paesi, e tramite interviste e analisi delle buste paga di 490 lavoratori di 19 diversi stabilimenti in Cina, India, Indonesia, Ucraina e Croazia.
Tutti i dati sono pubblicati sulla piattaforma FashionChecker.org.
Tra i marchi italiani contattati troviamo Benetton, Calzedonia, Falc, Geox, Gucci, OVS, Salewa.
I risultati dell’inchiesta rivelano innanzitutto il netto contrasto tra ciò che i grandi marchi della moda affermano e/o promettono riguardo sostenibilità e produzione etica, e la realtà presentata dai dipendenti che lavorano per questi colossi. La ricerca evidenzia che nessun brand paga un salario dignitoso ai propri lavoratori, costretti ad accettare condizioni di lavoro pessime e spesso occultate all’informazione pubblica.
Questa pratica porta all’aumento della povertà ed è quindi contro il primo obiettivo dell’Agenda 2030. Proprio per questo, certificazioni come “GOTS – Global Organic Textile Standard” o “GRS – Global Recycled Standard” assicurano retribuzioni e condizioni di lavoro dignitose lungo l’intera filiera produttiva.

Punto 3
“Salute e benessere”. Prendiamo come esempio un problema di cui si sta sentendo molto parlare – ma che sembra non toccarci direttamente – come la coltivazione del cotone convenzionale, ossia non biologico, dove vengono utilizzate sostanze nocive quali pesticidi e veleni vari. Questi incidono dannosamente non soltanto sulle persone che lavorano la fibra, ma anche sui consumatori finali, ovvero noi. Il cotone biologico certificato, invece, oltre a richiedere un quantitativo d’acqua nettamente inferiore per la coltivazione, non consente in nessun modo l’utilizzo di sostanze nocive.
Punto 5
“Parità di genere”. Tornando alla ricerca “Fuori dall’ombra: riflettori puntati sullo sfruttamento nell’industria della moda”, troviamo che l’80% dei lavoratori nel tessile sono donne fra i 18 ed i 24 anni. Molte di loro sono sottoposte a ripetuti abusi fisici e verbali, lavorano in condizioni non sicure senza alcuna assistenza sanitaria e con salari bassissimi che fanno anche emergere una discriminazione di genere. Ad esempio, in India le donne guadagnano in media solo l’88% di quello che guadagnano gli uomini e nessuna azienda intervistata ha fornito prove o informazioni pubbliche sui divari retributivi di genere nella propria catena di fornitura.
Punto 8
“Lavoro dignitoso e crescita economica”. Con la delocalizzazione delle industrie iniziata grazie all’accordo nordamericano per il libero scambio (Nafta), i grandi marchi di moda hanno iniziato a commissionare la creazione dei loro prodotti in paesi con paghe modeste, condizioni di lavoro precarie, rappresentanze sindacali inesistenti e norme a tutela dell’ambiente pressoché assenti.

Secondo delle indagini condotte dal movimento internazionale Fashion revolution, emerge che in Guandong (Cina) le donne più giovani svolgono fino a 150 ore mensili di straordinari, il 60% di loro non ha un contratto ed il 90% non ha accesso alla previdenza sociale. In Bangladesh i lavoratori del settore tessile guadagnano 44 dollari al mese, a fronte di un salario minimo pari a 109 dollari.
Citando nuovamente le indagini portate avanti dalla Clean clothes campaign, in Turchia i lavoratori guadagnano tra i 310 e i 390 euro al mese, circa un terzo del salario stimato come dignitoso.
Notiamo quindi, che in tutti questi distretti tessili impiegati per le produzioni dei marchi internazionali di moda, emerge come gran parte degli impiegati non arrivi neanche minimamente a guadagnare un salario dignitoso. Questa condizione impedisce di fatto di poter provvedere al sostentamento per sé stessi e la propria famiglia, di pagare un affitto, spese mediche, vestiti, o il diritto all’istruzione. Possibilità che non verrebbero precluse al lavoratore se gli fosse garantito un salario adeguato e una settimana di non più di 48 ore lavorative. Anche in questo caso, certificazioni come GOTS e GRS garantiscono e controllano (con verifiche annuali) che le condizioni di lavoro rispettino questi criteri e gli standard legali nazionali; verificano inoltre che i salari siano sopra il living wage.
Punto 6 e punto 14
“Acqua pulita e igiene” e “Vita sott’acqua”. Un altro enorme danno ecologico è collegato alle risorse idriche. Il 20% dell’inquinamento mondiale dipende dall’industria della moda, in particolare dallo smaltimento di tutte le sostanze tossiche con cui vengono trattati i capi diabbigliamento.

L’industria tessile e abbigliamento, includendo la coltivazione del cotone, è responsabile del consumo di circa 93 miliardi di metri cubi d’acqua all’anno. Circa il 4% dell’ammontare dell’acqua dolce globale. I punti presi in considerazione dall’Agenda 2030 sorgono proprio a causa dell’enorme portata di questi dati.
È pratica diffusa in molte fabbriche, infatti, riversare le acque reflue nelle risorse idriche naturali inquinando fiumi, mari, avvelenando i loro abitanti e, conseguentemente, l’uomo.
Anche il consumo di acqua va regolato: l’Onu stima che il 20% dell’acqua sprecata a livello globale sia imputabile a questo settore, che si aggiudica il secondo posto nella classifica globale, subito dopo l’agricoltura. Una persona impiega circa 10 anni a bere 10.000 litri di acqua, che è quasi la stessa quantità necessaria a produrre un chilo di cotone per un paio di jeans.
Complessivamente si stima che l’industria fashion consumi circa 79.000 miliardi di litri d’acqua all’anno, anche se altre stime fanno oscillare questo valore fino ai 200.000 miliardi. Numeri che fanno venire il mal di testa solo a pensarci!
Un’altra colossale preoccupazione riguarda il fatto che l’industria della moda è responsabile del 35% delle microplastiche che finiscono nei mari e negli oceani. Percentuale che si traduce in circa 190.000 tonnellate di microplastiche all’anno provenienti soprattutto del poliestere di cui il fast fashion fa un abuso smisurato.

Punto 12
“Consumo e produzione responsabili”. Oggi compriamo più di 80 miliardi di capi di abbigliamento all’anno, il 400% in più rispetto ai primi anni 2000. Compriamo sempre di più ma indossiamo sempre meno. Questo è l’approccio del consumatore su cui nasce e fonda il suo business il sistema chiamato fast fashion, che classifica gli abiti che acquistiamo da queste aziende come un prodotto “usa e getta”, spingendo a un sovra consumo e ad una produzione eccessiva di capi di abbigliamento, i quali andranno poi smaltiti. Basta pensare che ogni anno 16 milioni di tonnellate di rifiuti tessili vengono generati solo nell’Unione europea.
Lo sviluppo del fast fashion negli ultimi venti anni ha portato i vestiti a diventare sempre più economici e di bassa qualità. In tal modo le persone sono indotte a comprare sempre più abiti, perdono nel tempo l’abitudine di prendersi cura delle cose in quanto “costa meno ricomprarle che aggiustarle”. I vestiti vengono indossati per periodi molto brevi, per poi essere gettati.
Se la produzione annuale di indumenti continuerà a crescere alle attuali velocità, nel 2050 si arriverà a fabbricare tre volte l’attuale volume di produzione. Per arrivare a queste quantità verranno utilizzati 300 milioni di tonnellate di materiali non rinnovabili. Siamo consapevoli di ciò che questo comporterebbe? Siamo sicuri di voler continuare a investire le risorse in questo modo?
Punto 15
“Vita sulla terra”. L’industria della moda è direttamente collegata allo sfruttamento della terra e al processo di perdita della biodiversità attraverso l’uso improprio del suolo.

La coltivazione intensiva di cotone e l’utilizzo di sostanze chimiche nocive rappresentano una tra le principali cause di inquinamento del suolo. Come se non bastasse, bisogna considerare il problema della deforestazione dovuta allo sviluppo di fibre tessili a base di cellulosa come la viscosa, il rayon o il lyocell, la cui produzione sta aumentando notevolmente. Questo comporta la distruzione di foreste secolari e in via di estinzione, se non certificata. L’abuso di sostanze nocive (circa quindicimila tipologie di agenti chimici per la produzione di fibre) per contrastare la contaminazione delle piantagioni influisce negativamente sulla genuinità del suolo e sulla biodiversità.
Inoltre, in paesi come il Brasile, l’Amazzonia e il Paraguay, è diffusa la pratica di eliminare intere aree boschive per far spazio a pascoli di animali destinati all’industria alimentare e conciaria. Negli ultimi 30 anni 420 milioni di ettari sono stati deforestati, corrispondenti circa alla superficie dell’intera Unione Europea. Tale pratica mette a rischio i cosiddetti “polmoni verdi del mondo”, ripercuotendosi negativamente sugli equilibri climatici, sugli habitat terrestri e marini.
Questi dati sembrano usciti da un film su un futuro distopico vero?
Bhè, purtroppo un futuro del genere, di questo passo, non sarà più tanto lontano dalla realtà!
Dagli esempi appena analizzati emerge in modo chiaro come il mondo della moda sia tra i responsabili primari dell’inquinamento globale e del sottosviluppo di alcune aree geografiche. Questo rende ancora più evidente quanto sia necessaria una sostanziale politica correttiva per poter salvaguardare l’ambiente e l’uomo.
“Acqua pulita e servizi igienico-sanitari”, “Energia pulita e accessibile”, “Ridurre le disuguaglianze” “Città e comunità sostenibili”, “Consumo e produzione responsabili”, “Lotta contro il cambiamento climatico”, il settore tessile è coinvolto in tutti questi obiettivi. È tempo che tutti i grandi marchi di moda si assumano le responsabilità di ciò che producono e del loro smaltimento.

Ma anche noi consumatori possiamo e dobbiamo fare qualcosa per modificare le nostre cattive abitudini. Personalmente, mi capita spesso (purtroppo) di parlare con amici, conoscenti e sentire frasi come «Compro “capi del fast fashion” perché costano poco; dove altro trovo una t-shirt a 5 euro?». La domanda che invece dovremmo porci è «Come è possibile che una maglietta costi così poco? Cosa c’è dietro un indumento che viene venduto a questo prezzo?»
E’ arrivato il momento di cambiare le cose, e si sa, le grandi rivoluzioni partono sempre da noi!
Da consumatori dobbiamo capire che anche noi siamo parte attiva del programma redatto nell’Agenda 2030. Non è corretto continuare a sostenere con i nostri acquisti aziende che producono merce a discapito dell’ambiente e dei lavoratori. Il primo passo è quello di informarsi sulla provenienza dei prodotti, prediligere gli indumenti certificati e soprattutto rallentare il nostro ritmo di acquisto. Bisogna cambiare l’abitudine di comprare tanti capi di bassa qualità, per acquistare solo quello che serve veramente, considerando anche abiti di seconda mano e capi prodotti da chi rispetta l’ambiente ed i dipendenti.
È necessario riflettere su questi temi e ripensare gli approcci e le pratiche dell’industria dell’abbigliamento – nonché quelli di noi clienti finali – in chiave più sostenibile. Gli obbiettivi prefissati dall’Agenda 2030 e l’attenzione politica e sociale sono un ottimo punto di partenza, ma devono essere seguiti da politiche concrete. I governi, infatti, devono entrare in azione per regolamentare l’utilizzo delle materie prime, lo smaltimento dei rifiuti, rendere più facile il riuso e il riciclo, stabilire delle norme che rendano trasparenti e facilmente accessibili le informazioni sulla filiera di produzione e mettere fine all’era della moda usa e getta. Devono incentivare le aziende a progettare linee sostenibili, garantire servizi di riparazione dei capi ancora utilizzabili, assicurarci che i vestiti che compriamo siano stati realizzati da persone pagate adeguatamente, che lavorano in condizioni di sicurezza e senza distruggere il pianeta.
Conclusioni
In conclusione, per cambiare l’attuale situazione e raggiungere i 17 punti proposti dall’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, è necessario un triplo intervento congiunto da parte dei consumatori, dei governi e dei grandi marchi di moda, per portare avanti insieme una rivoluzione, sicuramente lenta ma efficace, per salvaguardare il nostro pianeta e tutti i suoi abitanti. Come consumatori è nostro dovere attivarci!